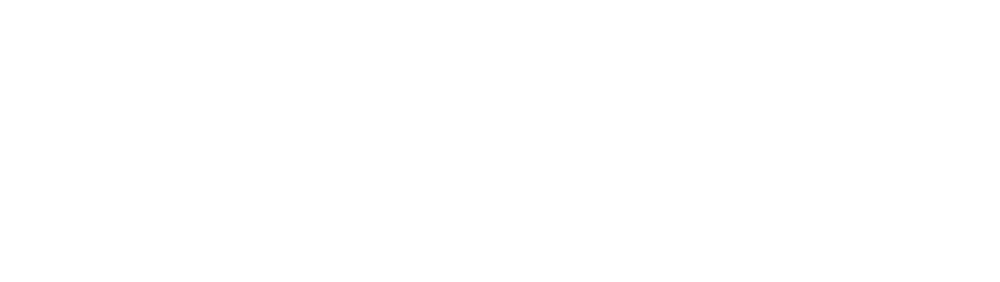L’immigrazione dall’Unità al primo dopoguerra
Bibliografia
Apri il menù
Se le migrazioni interne precedenti la Grande guerra sono poco studiate, ancora meno approfondite sono quelle dall’estero. Al primo censimento del Regno d’Italia (1861) i “nativi di stati esteri” risultano 88.639, mentre i “nativi del Regno” sono 21.688.695. Sono concentrati in Piemonte-Liguria (22.522), Lombardia (23.361), Toscana (10.094), Province Napoletane (8.453) e Romagna (7.479). Costituiscono una percentuale bassissima della popolazione totale e solo 71.205 (39.015 maschi e 32.190 femmine) dichiarano di aver eletto la Penisola a residenza permanente. Alcune tavole permettono inoltre di identificare più antichi nuclei d’immigrazione: i francofoni in Piemonte e Valle d’Aosta, i germanofoni degli alpeggi aostani e veneti, le “colonie” dalmate, albanesi e greche lungo la costa adriatica, in Calabria e in Sicilia, i catalofoni attorno ad Alghero. Sono inoltre menzionati gli “zingari” in Abruzzo, Molise e Puglia, ma non sono considerati allofoni, perché sono descritti come ultime vestigia di un nomadismo ormai italianizzato e sedentarizzato. o. Nel successivo censimento (1871) Lazio, Veneto e una parte del Friuli (le attuali province di Pordenone e Udine) sono divenuti parte dell’Italia; inoltre, agli stranieri è dedicato un volume specifico (Stranieri in Italia, 1874). Tuttavia, questi sono addirittura calati a 60.024, di cui un terzo di origine austro-ungarica (18.000). Agli inizi del Novecento la presenza straniera aumenta dunque grazie anche al legame con la mobilità turistica e l’iniziativa diplomatico-culturale. Questa crescita è parzialmente registrata dal censimento del 1911, ma è un fenomeno di breve durata: alcune comunità, infatti, si dissolvono allo scoppio della guerra, quando sono perseguitate perché originarie di nazioni nemiche (Caglioti, 2014).