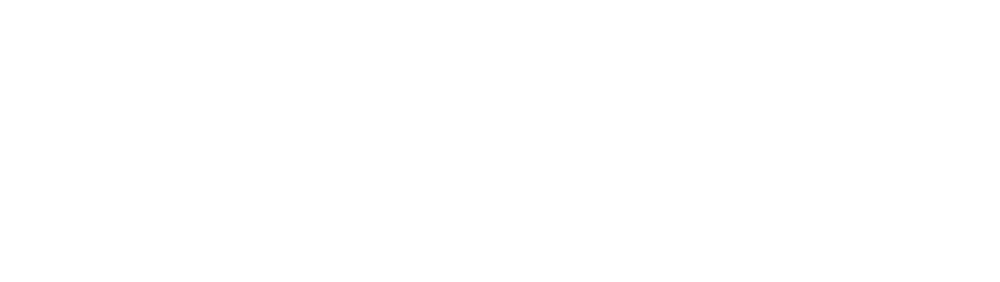Il progetto dei percorsi digitali sulle migrazioni umane fa parte del più ampio progetto “Progetto Cultural Regeneration: Ponte di Dialoghi fra Culture”
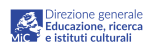
Sostenuto da “PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. Sub-Investimento 3.3.2:
– Sostegno ai settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale
(Azione A II) – TOCC0000278 – COR 15908103; CUP C87J23002200008”
Dall'antichità al Medioevo
L’immigrazione nell’Italia antica contribuì alla formazione della identità culturale e sociale del paese, con l’arrivo di popoli e genti da tutto l’Impero.
I flussi nell'età moderna
In epoca moderna, l’immigrazione in Italia, seppur contenuta, fu influente, legata al commercio e ai rifugi religiosi. Le città portuali divennero centri multiculturali.
Dall'unità al primo dopoguerra
Tra il 1861 e la Grande Guerra, l’immigrazione in Italia fu limitata e concentrata in alcune aree. Cresciuta all’inizio del '900, diminuì con la guerra.
Dal 2° dopoguerra agli anni ‘50
Dal secondo dopoguerra, anche l’Italia ha accolto rifugiati stranieri e profughi italiani dai territori perduti. Tra il 1945 e il 1952, circa 120.000 rifugiati furono assistiti da enti internazionali come UNRRA, IRO e, dal 1951, UNHCR.
Tra gli anni '70 al 2000
Tra gli anni ’70 e fine '90, l’Italia è diventata un paese di immigrazione. Il fenomeno, inizialmente limitato, si è stabilizzato con leggi come la Foschi, Martelli e Turco-Napolitano, rendendo l’immigrazione una componente strutturale della società.
Dal 2001 ad oggi
Dal 2000, l’immigrazione in Italia è cresciuta oltre i 5 milioni di residenti, diventando parte stabile della società. Diversificata per origine e ruolo nei servizi, ha visto dal 2015 un dibattito acceso e l'introduzione di restrizioni.